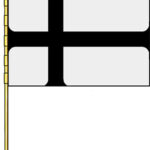Ordine dei Fratelli dell’Ospedale Tedesco di Santa Maria in Gerusalemme
Ordine dei Fratelli dell’Ospedale Tedesco di Santa Maria in Gerusalemme

Storia e informazioni
Nel 1190 alcuni cittadini di Brema e Lubecca, durante l’assedio di Acri (1189-1191), costruirono un ospedale da campo davanti alla città di San Giovanni d’Acri per i pellegrini malati e i crociati feriti, in particolare per quelli appartenenti alle nazioni germaniche e adottarono come una croce nera in campo bianco e il motto: HELFEN UND HEILEN (AIUTARE E GUARIRE). Secondo la leggenda la vela tesa in forma di tenda sui feriti sarebbe stato il primo ospedale. I confratelli organizzarono un ospedale vero e proprio che rimase in funzione anche dopo la conquista di Acri, adottarono le regole dell’Ordine dei Cavalieri di San Giovanni (Gerosolimitano, oggi “di Malta”).
Sul modello dei Templari e dei Gerosolimitani, dei quali adottarono le regole, si sviluppò rapidamente un Ordine religioso-cavalleresco: l’Ordine della Chiesa di Santa Maria dei Tedeschi o Ordine Teutonico (Ordo domus Sanctae Mariae Teutonicorum: “teutone” indica un abitante non celtico della regione germanica). La denominazione voleva ricordare un ospedale che si voleva esistesse a Gerusalemme fino al 1187 e l’auspicio che, dopo la vittoria sui musulmani, la sede principale dell’Ordine sarebbe stata costituita nella città di Gerusalemme.
L’Ordine fu il protagonista della sanguinosa “Crociata Tedesca” contro le popolazioni dell’est Europa del marzo 1198, e su iniziativa di Wolfger von Erla e Konrad von Querfurt, la comunità degli ex infermieri fu riconosciuta come Ordine cavalleresco da Papa Innocenzo III il 19 febbraio 1199. Il primo Gran Maestro fu Heinrich Walpot von Bassenheim.
Si articolò in quattro categorie: cavalieri, preti, sergenti e confratelli. I combattenti erano i cavalieri, che indossavano un mantello bianco con croce nera, e i sergenti, che portavano mantello scuro con la croce nera bordata di bianco. Era governato da un Capitolo Generale, con a capo un Gran Maestro, l’Ordine era diviso in regioni, province e case. Acquistò terre in Palestina, Grecia, Italia meridionale e soprattutto in Germania, ma indirizzò e concentrò la sua attività verso i confini orientali dell’Europa cristiana: il gran maestro Hermann von Salza (1211-1239) si impegnò nella lotta contro i Cumani di Transilvania (1211-25) attuando la colonizzazione tedesca di quella regione, poi contro le popolazioni baltiche pagane della Prussia.
Con la bolla d’oro rilasciata dall’imperatore Federico II nel 1226), l’Ordine fu investito delle terre prussiane, conquistate fra il 1230 e il 1280; nel 1237, incorporando i resti dell’Ordine dei Cavalieri Portaspada (detti “di Livonia”), si affermò anche in Livonia, ma l’espansione fu frenata dalla resistenza dei principi russi e lituani.
Stabilita la propria sovranità sulla città di Danzica nel 1308, sull’Estonia, sull’isola di Gotland e sulla parte nord-orientale del Brandeburgo (1402), l’Ordine raggiunse la massima estensione territoriale, toccando il suo apice economico e culturale.
Dopo l’unione polacco-lituana, la sua fortuna si avviò al declino: la sconfitta di Tannenberg (o di Grunwald) del 1410, contro Ladislao II Jagellone, fu aggravata dalle lotte interne scoppiate fra la nobiltà, le città (i cosiddetti Stati) e il potere del gran maestro.
Gli Stati, anzi, crearono la cosiddetta Unione Prussiana e, con l’appoggio polacco, lottarono per tredici anni contro l’Ordine che, con la pace di Toruń (1466), dovette cedere alla Polonia la Pomerelia e la Varmia, con le città di Danzica, Elbing e Marienburg. L’ultimo gran maestro, Alberto di Brandeburgo-Ansbach, abbracciò la Riforma e fu investito duca di Prussia (1525) da Sigismondo Augusto di Polonia.
Poiché la secolarizzazione non fu riconosciuta né dall’imperatore né dal papa, l’Ordine continuò a vivere nei suoi antichi possedimenti disseminati in Germania, in Austria e nei Paesi Bassi. Soppresso nel 1809 da Napoleone e ricostituito in Austria da Francesco I (1834), fu combattuto dal nazionalsocialismo che pure ammirava la loro storia, infine venne ricostituito nel 1945 in Germania e in Austria.
.
Attraverso donazioni ed lasciti, l’Ordine acquisì considerevoli patrimoni, possedimenti terrieri e numerosi ospedali in tutta Europa.
Nel 1221 l’ordine riuscì ad ottenere, mediante un privilegio generale pontificio, la piena esenzione dal potere diocesano dei vescovi. Le entrate aumentarono concedendo il diritto di fare collette comprensive anche nelle parrocchie non assegnate all’Ordine. Dietro congruo compenso (legato), le persone bandite o interdette potevano essere sepolte anche in “terra consacrata” nei cimiteri delle chiese religiose teutoniche, cosa che altrimenti sarebbe stata loro negata. L’ordine era ecclesiasticamente direttamente soggeto al papa, quindi sullo stesso piano degli Ospitalieri e dei Templari, questi però vedevano l’Ordine Teutonico con crescente scetticismo, anche a causa delle sue enormi acquisizioni. Addiritura i Templari rivendicarono l’esclusiva del mantello bianco e presentarono una protesta ufficiale a papa Innocenzo III nel 1210.
Fu solo nel 1220 che ai Cavalieri Teutonici fu concesso di indossare il controverso mantello da Papa Onorio III. I Templari, tuttavia, rimasero acerrimi rivali dell’Ordine Teutonico e in Palestina scoppiò una guerra vera e propria. Nel 1241 i Templari li scacciarono da (quasi) tutti i loro possedimenti e non tollerarono più nemmeno il loro clero nelle chiese.
L’ordine acquisì i suoi primi possedimenti in Europa già alla fine del XII secolo. Un ospedale dell’ordine fu menzionato per la prima volta a Barletta, nell’Italia meridionale, nel 1197. Il primo insediamento nel territorio del Sacro Romano Impero a nord delle Alpi fu un ospedale ad Halle intorno al 1200: l’ospedale di Sankta Kunigunden, su un sito donato a ovest della città, che prese il nome dall’imperatrice santa Kunigunde (Cunegonda), moglie di Enrico II. I possedimenti territoriali sparsi divennero presto così estesi che già nel 1218 dovette essere nominato un Comandante Rurale per la sola Germania. Nei decenni successivi l’ordine si diffuse in tutto l’impero, sostenuto da numerose fondazioni e dall’adesione di nobili eminenti e facoltosi.
L’Ordine Teutonico sostenne senza riserve la Crociata dell’imperatore Federico II nel 1228/1229, nella quale il Gran Maestro Hermann von Salza giocò un ruolo chiave. Ciò fece guadagnare all’Ordine l’esenzione feudale in aggiunta a quella ecclesiastica.
Questo importante privilegio non lo liberò dall’associazione feudale al Regno di Gerusalemme, ma lo liberò da ogni obbligo nei suoi confronti. L’imperatore Federico II, che fu anche re di Gerusalemme in seguito al matrimonio con Isabella di Brienne, volle assegnare all’Ordine in un posto di rilievo ed Hermann von Salza, era uno dei più importanti e ascoltati consiglieri nonché diplomatico dell’imperatore. Nel 1226 l’imperatore concesse molti altri privilegi, con la Bolla d’oro di Rimini del 1226.
Nel 1241 contingenti di cavalieri sostennero i territori dell’Europa centrale colpiti dall’attacco degli eserciti mongoli guidati da Batu Khan. Nella perduta battaglia di Liegnitz, ad esempio, l’intero contingente dell’Ordine schierato a difesa della Slesia fu annientato.
In Terra Santa, l’Ordine riuscì acquisì, il castello di Montfort (1220), le signorie di Toron (1229) e Schuf (1257) e il castello di Toron di Banyas (1261).
Con la caduta dell’ultimo baluardo crociato di Acri nel 1291, il coinvolgimento militare dell’Ordine Teutonico in Terra Santa terminò. A differenza delle multinazionali degli Ospitalieri e dei Templari, la presenza dell’Ordine Teutonico si concentrò successivamente entro i confini orientali dell’Impero e nelle basi appena acquisite in Prussia. Per la temporanea speranza di riconquistare la Terra Santa, la sede del Gran Maestro rimase a Venezia, importante porto per la traversata verso la Terra Santa, fino al 1309.
In considerazione dei possedimenti frammentati, sembra che il Gran Maestro Hermann von Salza abbia cercato presto di stabilire un territorio coerente dominato dall’Ordine Teutonico. In questo contesto è da comprendersi l’accettazione della richiesta di aiuto del Andrea II d’Ungheria nel 1211, in un momento in cui le forze disponibili dell’ordine erano effettivamente impegnate per liberare la Terrasanta. Il re offrì all’Ordine di acquisire i diritti nel Burzenland, in Transilvania attraverso la guerra contro i Cumani. Permise di incamerare le decime ecclesiastiche, di coniare monete e di fortificare i castelli con murature in pietra (in Ungheria quest’ultimo era considerato un privilegio speciale del re).
Tuttavia, i rapporti dell’Ungheria con l’Ordine Teutonico si deteriorarono presto e crebbe il risentimento antitedesco, che portò anche all’omicidio di Gertrud von Andechs nel 1213, moglie di origine tedesca di Andrea II.
Nel 1223, papa Onorio III concesse l’esenzione, per il Burzenland, dall’autorità regia, e la nobiltà ungherese esortò fortemente il re a resistere all’esecuzione dell’ordine papale, che si cercò di imporre l’anno successivo, grazie all’insistenza di Hermann von Salza, ponendo il Burzenland sotto la diretta “protezione” della Sede Apostolica. Andrea II intervenne e l’esercito ungherese, numericamente superiore, assediò e conquistò i pochi castelli dell’ordine.
Il tentativo dell’Ordine Teutonico di stabilire un territorio autonomo al di fuori del Regno d’Ungheria, basandosi sulla “legge sulla patria” concessa e con l’attivo sostegno del Papa, si concluse negativamente nel 1225 con l’espulsione dell’Ordine e la distruzione dei suoi castelli.
Un secondo tentativo di acquisire terreni ebbe successo nella regione baltica. Già nel 1224 l’imperatore Federico II da Catania aveva posto gli abitanti pagani della terra prussiana a est della Vistola e delle zone limitrofe, sotto il controllo della Chiesa e dell’Impero come “liberi imperiali”. Guglielmo da Modena, in qualità di legato pontificio per la Livonia e la Prussia, lo confermò nello stesso anno.
Nel 1226, il duca polacco di Mazovia, Corrado I Piast, chiese aiuto all’Ordine Teutonico nella sua lotta contro i prussiani per il Kulmerland. Dopo le sfortunate esperienze con l’Ungheria, questa volta l’Ordine Teutonico si è assicurato legalmente. Sia l’imperatore Federico II che il papa Gregorio IX garantirono che, dopo che gli stati baltici, le terre conquistate sarebbero appartenute all’Ordine. Su sua insistenza l’ordine ricevette anche l’assicurazione che, in quanto sovrano di questa zona, sarebbe stato subordinato solo al Papa e non ad alcun feudatario secolare. Dopo un lungo periodo di esitazione, Corrado I di Masovia cedette il Kulmerland all’Ordine “per sempre” con il trattato di Kruschwitz del 1230. L’Ordine Teutonico considerava questo trattato come uno strumento per creare un territorio indipendente in Prussia. La sua formulazione e autenticità del documento del trattato sono state però messe in dubbio da alcuni storici.
Nel 1231 il Landmeister Hermann von Balk attraversò la Vistola con sette cavalieri e circa 700 uomini. Nello stesso anno costruì il suo primo castello, a Thorn, nel Kulmerland. Da qui l’Ordine Teutonico iniziò la progressiva conquista del territorio a nord della Vistola. La conquista fu accompagnata da insediamenti mirati, di solito agli insediamenti fondati dall’ordine veniva concesso il diritto documentato nel Kulm Handfest. Nei primi anni l’Ordine fu sostenuto da Corrado di Masovia e dagli altri principi polacchi, nonché dagli eserciti crociati dell’Impero e di molti paesi dell’Europa occidentale. Papa Gregorio IX concesse ai partecipanti alla campagna militare contro i prussiani il completo perdono dei peccati e altre promesse di salvezza consuete per una crociata in Terra Santa.
I pochi cavalieri membri dell’Ordine dei Fratelli di Dobrin (Fratribus militiae Christi in Prussia) furono incorporati nell’Ordine Teutonico nel 1235, per decisione del Papa (l’ordine fu fondato nel 1228 su iniziativa di Corrado per proteggere il cuore della Masovia, ma non fu in grado di affermarsi militarmente contro i prussiani).
L’ Ordine dei Fratelli della Spada o “Portaspada”, fondato a Riga nel 1202 (insegne: mantello bianco con croce rossa), subì una devastante sconfitta contro i lituani shamaiti e i semigalliani nella battaglia di Schaulen nel 1236. Hermann von Salza ne negoziò personalmente l’Unione avvenuta nel 1237, ma l’espansione verso est dell’Unione Livoniana terminò presso il fiume Narva . Dopo che Pskov fu temporaneamente occupata nel 1240, ci furono continue battaglie tra i cavalieri del ramo livoniano dell’ordine e i seguaci dei vescovi livoniani e dei dipartimenti russi. Questi culminarono nell’aprile 1242 nella battaglia del lago ghiacciato Peipus (nota anche come “battaglia sul ghiaccio”), il cui esatto svolgimento e la cui portata sono controversi tra gli storici. Di fatto un contingente russo al comando di Alexander Nevsky, il principe di Novgorod, sconfisse qui un distaccamento militare più numeroso guidato da Hermann I von Buxthoeven, vescovo di Dorpat . Nell’estate del 1242 fu concluso un trattato di pace che ha effettivamente fissato le rispettive sfere di influenza per più di 150 anni.
L’assoggettamento dell’area prussiana fu accompagnato dalla “cristianizzazione tedesca” e dall’insediamento di coloni del paese. Impresa che occupò l’Ordine per più di 50 anni e fu completata solo nel 1285 ma con gravi battute d’arresto, e diverse rivolte dei prussiani. L’obiettivo originariamente legittimante della cosiddetta “missione anti pagana” fu mantenuto anche dopo l’avvenuta cristianizzazione della Prussia.
L’Ordine divenne l’unico membro non cittadino della Lega Anseatica e mantenne una filiale a Lubecca presso la corte dell’Ordine Teutonico, lo Stato religioso era una delle comunità più moderne e prospere del tempo. Innovazioni di vasta portata nel campo dell’agricoltura così come innovazioni pragmatiche nel campo della produzione artigianale in combinazione con un’amministrazione efficiente e un’economia monetaria altamente sviluppata caratterizzano una struttura organizzativa che è superiore alla tradizione feudale sistema.
Il Gran Maestro mantenne il suo quartier generale ad Acri fino al 1291, quando la città andò perduta. Konrad von Feuchtwangen trasferì quindi la sede a Venezia , (tradizionale e importante porto per l’imbarco verso Outremer).
Nel 1309 il Gran Maestro Siegfried von Feuchtwangen trasferì la sua sede nel colossale castello di Marienburg sul fiume Nogat. La Prussia divenne il centro dell’Ordine nello stesso periodo nel quale l’Ordine dei Templari fu perseguitato dal re Filippo IV di Francia , sostenuto dal compiacente papa Clemente V. Gli ordini cavallereschi furono tutti comunque al centro delle critiche generali nel primo decennio del XIV secolo a causa della perdita della Terra Santa e del loro scopo formale della sua difesa.
La conquista di Danzica e della Pomerania nel 1308 avvenne attraverso un’azione militare contro gli interessi polacchi e sulla base del Trattato di Soldin con il Margraviato di Brandeburgo. In Polonia, anche a causa di questi avvenimenti, crebbe il risentimento contro l’Ordine Teutonico e anche contro i tedeschi in generale che vivevano nel resto della Polonia. Nel 1312 a Cracovia fu repressa la rivolta del balivo Alberto e alcuni tedeschi che non avevano superato un semplice test di lingua polacca furono espulsi da Cracovia. La Polonia dell’era Piast, che era stata frammentata dal dominio territoriale, fu parzialmente unificata e infine consolidata come Regno di Polonia negli anni successivi da Ladislao I Jaghellone (Władysław I Ellenlang). Soprattutto l’arcivescovo Jakub Świnka di Gnesen e primate di Polonia rappresentò una politica di demarcazione contro i tedeschi.
I conflitti tra l’Ordine e i sovrani polacchi sorti in seguito alla perdita della Pomerania e di Danzica si trasformarono successivamente in una faida permanente. Il Trattato di pace di Kalisz, con il quale la Polonia rinunciò ufficialmente alla Pomerania e Danzica nel 1343 senza rinunciare ai propri titoli legali, determinò una distensione a medio termine tra l’Ordine e la Polonia che durò quasi 70 anni.
Nella Lituania nel sud-est si formò gradualmente un granducato, contro il quale l’Ordine condusse una guerra costante sia per ragioni ideologiche che territoriali. Le guerre di Lituania dell’Ordine Teutonico durarono oltre un secolo dal 1303 al 1410. Poiché questo granducato orientale rifiutò con veemenza il battesimo, i lituani furono ufficialmente considerati gli ultimi pagani d’Europa e nemici della Cristianità.
Il Gran Maestro Winrich von Kniprode condusse lo Stato religioso e quindi l’Ordine alla sua massima prosperità. Un’economia consolidata e successi militari sostenuti contro la Lituania furono la chiave del successo. Il numero dei fratelli cavalieri rimase tuttavia piccolo; intorno al 1410 si contavano circa 1.400 cavalieri, e intorno alla metà del XV secolo si contavano solo 780 religiosi.
Durante il gran magistrato di Konrad von Jungingen, la massima espansione dell’ordine fu raggiunta con la conquista del Gotland e l’acquisizione pacifica di Neumark e Samaitens. La conquista di Gotland nel 1398 fece terminare gli atti di pirateria dei fratelli Vitalien che vi erano accampati. Nel 1408 che fu raggiunto un accordo con la regina Margherita I di Danimarca, che pagò circa 63 chilogrammi d’oro per mantenerne il possesso.
Nel 1386, i due principali oppositori dell’ordine si unirono attraverso il matrimonio del granduca di Lituania Jogaila con la regina Edvige di Polonia. All’inizio dell’agosto del 1409, il Gran Maestro Ulrich von Jungingen inviò ai suoi avversari le “lettere di faida”, dichiarando guerra.
Il 15 luglio 1410, una forza unita polacco-lituana sconfisse l’esercito dell’Ordine, battaglia di Tannenberg dove trovò la morte anche il Gran Maestro Ulrich von Jungingen, quasi tutti i comandanti dell’ordine e numerosi cavalieri.
L’ordine fu tuttavia in grado di preservare il nucleo dei suoi territori prussiani, compreso Marienburg, grazie agli sforzi del comandante e poi Gran Maestro Heinrich von Plauen e di mantenerlo nella Prima Pace di Thorn del 1411. Con questo trattato di pace e la sua aggiunta nella pace di Melnosee nel 1422, cessarono le campagne militari dell’Ordine contro la Lituania (e contro la successiva unione personale della Polonia-Lituania). Tuttavia, nella pace di Thorn, si dovette versare un contributo elevato di 100.000 groschen boemi d’oro per, tra le altre cose, il riscatto dei prigionieri. I contributi portarono all’introduzione di un’imposta speciale, la cosiddetta Schoss, che contribuì a un carico fiscale insolitamente elevato sui possedimenti prussiani.
Verso la fine del XIV secolo la nobiltà ridusse sempre più gli ordini cavallereschi a una base di approvvigionamento sicura per i discendenti che non avevano diritto all’eredità. Di conseguenza, la motivazione del cavalierato decadde. I compiti quotidiani nell’amministrazione o nell’amministrazione dell’Ordine Teutonico erano ormai percepiti come compiti fastidiosi. Anche la liturgia conservatrice dell’ordine contribuì a questa visione, dato che la routine quotidiana in tempo di pace era meticolosamente e rigidamente regolata.
Inoltre, su istigazione del re di Polonia al Concilio di Costanza (1414–1418), all’Ordine fu formalmente vietata ogni ulteriore attività missionaria in Lituania, che ora era ufficialmente cristiana.
Nella crisi seguita alla grave sconfitta del 1410, i risentimenti si allargarono. Le controversie interne indebolirono sia l’ordine stesso che, di conseguenza, lo Stato dell’ordine. I gruppi nazionali combattevano per garantirsi l’influenza all’interno, il maestro tedesco lottava per l’indipendenza dal gran maestro.
Le città della Prussia e la nobiltà fondiaria di Kulm nel 1440 si unirono per formare la Confederazione prussiana. Il Gran Maestro Ludwig von Erlichshausen aggravò il conflitto con le sue esose richieste sui possedimenti. L’imperatore Federico III si schierò con l’Ordine alla fine del 1453. In occasione delle nozze del re Casimiro IV di Polonia con Elisabetta d’Asburgo, all’inizio del 1454 la Confederazione prussiana stipulò un’alleanza protettiva con la Polonia e si ribellò apertamente al governo dell’Ordine.
Scoppiò allora la Guerra dei Tredici Anni, caratterizzata da assedi e incursioni, ma quasi nessuna battaglia campale. Già nel settembre del 1454 le truppe polacche furono sconfitte nella battaglia di Konitz e successivamente appoggiarono solo marginalmente la rivolta prussiana. Alla fine, a causa dell’esaurimento generale, si arrivò ad una situazione di stallo. L’Ordine non poteva più pagare i suoi mercenari e per questo motivo dovette rinunciare addirittura alla sua sede principale, il castello di Marienburg che fu dato in pegno ai mercenari non pagati, che lo vendettero al re di Polonia. Alla fine, il fattore decisivo fu la maggiore forza finanziaria delle città ribelli, Danzica in particolare, che pagarono da sole tutte le spese di guerra.
Nella Seconda Pace di Thorn del 1466, l’ordine perse anche Pomerania, Kulmerland, Warmia e Marienburg. Questo trattato non fu riconosciuto né dall’imperatore né dal papa. Ma l’Ordine nel suo insieme doveva riconoscere la sovranità feudale polacca, che da allora in poi ogni nuovo Gran Maestro cercò di evitare ritardando o addirittura omettendo di prestare giuramento di fedeltà. Gran parte delle città e dei territori prussiani dell’ovest riuscirono a staccarsi dal dominio dell’Ordine in seguito al Trattato.
Per mantenere lo stato religioso, che si era ristretto nel territorio, erano ora necessari i sussidi degli ufficiali giudiziari del Sacro Romano Impero, che mettevano molti di coloro che vi si recavano in una difficile situazione finanziaria. Il maestro tedesco Ulrich von Lentersheim cercò di liberarsi da questi doveri, successivamente chiese di propria iniziativa l’appoggio dell’imperatore e, a questo scopo, si sottomise alla sovranità feudale di Massimiliano I nel 1494. Tuttavia, questo approccio contraddiceva i trattati di Kujawisch Brest e Thorn con la Polonia, che portò alle proteste del ramo prussiano dell’ordine e soprattutto del Regno di Polonia.
Il Gran Maestro Alberto (Albrecht) di Brandeburgo-Ansbach tentò senza successo di ottenere l’indipendenza dalla corona polacca nella cosiddetta Guerra equestre (1519–1521). Nella speranza di ricevere sostegno dal Sacro Romano Impero, nel 1524 pose il territorio dell’ordine prussiano sotto la sovranità dell’impero e intraprese lui stesso un viaggio nell’impero, ma senza successo.
Nel frattempo, però, aveva fatto una scelta personale importante: nel 1522 aderì agli insegnamenti di Martino Lutero e quindi alla Riforma, che determinò la questione su cosa sarebbe dovuto diventare un Ordine religioso. Per questo si rivolse direttamente a Lutero, recentemente bandito dall’impero, che consigliò di “secolarizzare” lo Stato religioso, rinunciando alla carica di gran maestro e trasformando la Prussia in un ducato secolare . Così facendo Alberto I di allontanò dall’imperatore ma ottenne l’appoggio del re di Polonia, che aveva precedentemente combattuto nella guerra di cavalleria. Alberto, che era nipote del re polacco Sigismondo I tramite sua madre Sofia, prestò giuramento di fedeltà al re polacco nel 1525; in cambio gli fu affidato il ducato ereditario in Prussia (cioè “nella” e non “della” Prussia, perché la parte occidentale della Prussia era direttamente sotto il patronato del re di Polonia). Dal 9 maggio 1525 l’ex Gran Maestro risiedette a Königsberg, come duca Alberto I di Prussia.
Le istituzioni del Sacro Romano Impero non riconobbero il secolare Ducato di Prussia, e continuarono a nominare formalmente gli amministratori della Prussia fino alla fine del XVII secolo.
Il ramo dell’ordine rimasto fedele all’Impero non accettò la trasformazione del “suo” stato: un capitolo generale convocato frettolosamente reinsediò il precedente maestro tedesco Walther von Cronberg come capo il 16 dicembre 1526, e nel 1527, ricevette dall’imperatore le insegne e il diritto di chiamarsi Amministratore del Gran Magistero e mantenere così il suo diritto di pretensione al possesso della Prussia.
Fu solo nel 1530 che un decreto imperiale permise a Cronberg di chiamarsi Gran Maestro (che diede poi origine al breve titolo Hoch- und Deutschmeister ) che fu contemporaneamente proclamato amministratore e infeudato alla Prussia dall’imperatore Carlo V alla Dieta Imperiale di Augusta nel 1530 .
Cronberg fece quindi causa al suo ex gran maestro, il duca Alberto, davanti alla Corte della Camera Imperiale. Il processo si concluse nel 1531 con l’imposizione del bando imperiale al duca Alberto e l’ordine allo stesso e alla Confederazione prussiana di concedere nuovamente all’ordine i suoi tradizionali diritti in Prussia. Ma le misure non ebbero alcun effetto: la Prussia aderì alla Riforma luterana e la Warmia, sottratta alla sovranità dell’Ordine già dal 1466, divenne un principato vescovile e divenne il punto di partenza della Controriforma in Polonia.
Nel 1561, i possedimenti del ramo livoniano dell’ordine, cioè Curlandia e Semigallia, furono convertiti in un ducato secolare sotto l’ex maestro, il duca Gotthard von Kettler . La Livonia vera e propria si unì direttamente alla Lituania e formò una sorta di co-dominio delle due parti dello stato nel successivo stato Polonia-Lituania.
I ducati di Prussia, Livonia, Curlandia e Semigallia erano ora soggetti alla sovranità polacca.
In considerazione della minaccia russa e rappresentata dai loro cavalierati , l’Estonia settentrionale con Reval (Tallinn) e l’isola di Ösel ( Saaremaa ) si sottomisero rispettivamente alla sovranità danese e svedese.
Nel 1629 la maggior parte della Livonia passò alla Svezia attraverso le conquiste di Gustavo II Adolfo; solo la Livonia sudorientale ( Latgallia ) attorno a Dünaburg (Daugavpils) rimase polacca e divenne il Voivodato di Livonia, chiamato anche “Livonia polacca”.
Dopo la fine della Grande Guerra del Nord, la Livonia con Riga e l’Estonia furono incorporate nell’Impero russo nel 1721 sotto forma dei cosiddetti Governatorati del Mar Baltico. Latgale entrò nell’Impero russo nel 1772, e Curlandia e Semigallia solo nel 1795 come parte delle spartizioni polacche.
Dopo il 1525, la sfera di attività dell’Ordine Teutonico fu limitata ai suoi possedimenti nel Sacro Romano Impero, ad eccezione della libera flotta in Livonia. Sin dalla Riforma l’ordine divenne triconfessionale: c’erano comunità cattoliche, luterane (come la Sassonia e leTuringia ) e miste (l’ Assia).
Dopo la perdita dei possedimenti prussiani, l’ordine riuscì a consolidarsi sia esternamente che internamente sotto Walther von Cronberg. Al Capitolo generale di Francoforte del 1529 fu promulgata la Costituzione Cronberg, la futura legge costituzionale della corporazione aristocratica. Mergentheim divenne la residenza del capo dell’ordine e allo stesso tempo la sede delle autorità centrali delle aree direttamente subordinate al Gran Maestro (il Magistero di Mergentheim) .
Al di fuori di questo dominio territoriale, che si adattò alle nuove condizioni, i balivi guidati dai comandanti rurali si svilupparono in entità largamente indipendenti. Alcuni di essi avevano il rango di possedimenti imperiali ed erano inseriti nel registro imperiale nel gruppo dei prelati. Spesso diventavano dipendenti dalle famiglie nobili vicine, che mandavano i loro figli nell’Ordine. In Turingia, Sassonia, Assia e Utrecht, dove le nuove dottrine religiose si erano saldamente affermate, c’erano anche fratelli religiosi luterani e riformati che – seguendo il pensiero corporativo della nobiltà – si comportarono lealmente verso il Gran Maestro, vissero anche nel celibato, e sostituirono la formula del voto da un giuramento solenne.
Dopo il 1590, il Gran Maestro e il Maestro tedesco fu scelto tra le principali famiglie degli stati territoriali cattolici, in particolare della Casa d’Asburgo. Ciò creò nuovi legami familiari e politici con la nobiltà tedesca, ma rese anche l’ordine sempre più uno strumento della politica di potenza asburgica.
In questo contesto, nel XVI secolo iniziò un cambiamento interno nell’ordine che portò a un ritorno al suo orientamento originale e le regole dell’ordine furono adattate alle nuove circostanze. Nel corso del XVI secolo, la mentalità borghese della nobiltà, che tendeva a spingere all’esclusività, ridusse l’importanza dei fratelli sacerdoti, per lo più non nobili, che non avevano né un seggio né un voto nel Capitolo Generale. La cura pastorale venne spesso affidata a membri di altri ordini spirituali. Da quando negli uffici dell’ordine iniziarono a lavorare laici con formazione giuridica, questa attività non fu più disponibile per i fratelli sacerdoti. Di conseguenza, il loro numero crollò.
La direzione dell’Ordine seguì le richieste del Concilio di Trento e decise di fondare nuovi seminari. Ciò avvenne a Colonia nel 1574 e a Mergentheim nel 1606. Il fondatore di quest’ultimo seminario fu il Gran Maestro Arciduca Massimiliano d’Austria, su iniziativa del quale anche il Tirolo era rimasto cattolico. In generale, si può notare che le proprietà appartenenti all’Ordine Teutonico rimasero cattoliche anche nelle aree prevalentemente riformate, il che continua ad avere conseguenze anche al giorno d’oggi. I rami dell’Ordine nelle aree protestanti hanno svolto un ruolo importante nella cura pastorale dei cattolici che viaggiavano attraverso il paese o dei pochi vecchi credenti rimasti. In alcuni eventi riemerse l’idea della confraternita ospedaliera. Tra le altre cose, nel 1568 l’ordine costruì un ospedale a Francoforte-Sachsenhausen.
Tuttavia, l’Ordine, ancora influenzato dalla nobiltà e dai suoi valori, vedeva il compito più importante nell’impegno militare dei fratelli cavalieri. Le guerre turche, che si erano intensificate a partire dal XVI secolo, offrirono un vasto campo di attività per la difesa statutaria della fede cristiana. Nonostante le difficoltà finanziarie, l’Ordine diede un contributo significativo – nel gergo dell’epoca – alla difesa dell’Occidente contro l’Impero Ottomano . I cavalieri professi prestavano servizio principalmente come ufficiali nei reggimenti dei principi imperiali cattolici e nell’esercito imperiale. In particolare, il Reggimento di Fanteria Imperiale N. 3 e il reggimento di fanteria austro-ungarico “Hoch- und Deutschmeister” n. 4 attiravano le loro reclute dalle zone di comando tedesche.
Tutti i fratelli cavalieri normodotati dovevano completare un cosiddetto exercitium militare prestando servizio per un periodo di tre anni con il grado di ufficiali nelle fortezze di confine che erano particolarmente a rischio a causa delle campagne militari prima che fosse loro permesso di assumere ulteriori incarichi religiosi.
Le guerre di coalizione scaturite dalla Rivoluzione francese alla fine del XVIII secolo furono la causa di un’altra grave crisi per l’Ordine. Con la cessione della riva sinistra del Reno alla Francia, i territori dell’Alsazia e della Lorena andarono completamente perduti, così come Coblenza e Biesen. La Pace di Pressburgo con la Francia dopo la pesante sconfitta della coalizione austro-russa ad Austerlitz contro Napoleone nel 1805 decretò che i possedimenti dell’Ordine Teutonico e la carica di Gran Maestro e Tedesco passassero ereditariamente alla Casa d’Austria, cioè agli Asburgo: la carica di Gran Maestro e con essa l’ordine furono integrati nella sovranità dell’Impero austriaco. Tuttavia, l’imperatore Francesco I d’Austria permise che lo status nominale dell’Ordine continuasse ad esistere. Il Gran Maestro in quel momento era suo fratello Anton Viktor d’Austria.
Il colpo successivo arrivò con lo scoppio di un nuovo conflitto militare del 24 aprile del 1809, quando gli austriaci invasero il Regno di Baviera in seguito alla guerra della quinta coalizione, Napoleone dichiarò decaduto l’Ordine negli Stati della Confederazione renana.
I possedimenti dell’Ordine furono ceduti ai principi della Confederazione del Reno. Lo scopo di Napoleone era in questo modo quello di compensare materialmente i suoi alleati per il loro impegno nella guerra contro la coalizione e quindi di legare più strettamente i principi all’Impero francese. L’ordine contava ora solo i possedimenti in Slesia e Boemia nonché il territorio austriaco.
Nell’ambito della secolarizzazione dell’inizio del XIX secolo, l’Ordine perse la maggior parte dei suoi territori, sebbene fosse ancora riconosciuto come sovrano nella Reichsdeputationshauptbildung. Nel 1805 l’Imperatore di Germania e d’Austria stabilirà l’ereditarietà, personale e in linea retta maschile. L’ordine era così entrato a far parte dell’Austria e della monarchia asburgica .
In seguito al Congresso di Vienna del 1815 le province della Carniola e del Tirolo entrarono a far parte dell’Austria e tornarono quindi sotto il controllo dell’Ordine; Tuttavia, a causa del patrimonio ormai insufficiente, il ripristino della piena sovranità non era più possibile.
Nel 1834 Francesco I rinunciò nuovamente a tutti i diritti derivanti dalla pace di Pressburgo e restaurò l’Ordine con i suoi antichi diritti e doveri: con decreto ministeriale dell’8 marzo 1843 l’Ordine divenne giuridicamente un istituto spirituale-militare indipendente sotto il vincolo di un immediato feudo imperiale. Esistevano ancora i Balivati di Austria, il Magistero in Boemia e Moravia ed un piccolo Balivato a Bolzano.
Dopo il crollo della monarchia asburgica a seguito della prima guerra mondiale, negli Stati successori della monarchia multietnica l’ordine fu inizialmente visto come l’Ordine d’Onore Imperiale Asburgico. Pertanto le autorità competenti valutarono la confisca dei beni dell’ordine come proprietà nominale della famiglia imperiale asburgica. Per questo motivo il Gran Maestro Arciduca Eugenio d’Austria-Teschen si dimise dal suo incarico nel 1923 e fece eleggere coadiutore il sacerdote dell’ordine e vescovo di Brno Norbert Johann Klein e quindi abdicò.
Questa svolta si rivelò vincente: alla fine del 1927 gli stati successori della monarchia danubiana riconobbero l’Ordine Teutonico come Ordine spirituale: comprendeva ancora le quattro sfere (in seguito chiamate province) del Regno d’Italia, della Repubblica Cecoslovacca , della Repubblica d’Austria e del Regno di Jugoslavia.
Il 6 settembre 1938 il governo nazionalsocialista tedesco emanò un decreto di scioglimento dell’Ordine Teutonico e nello stesso anno, come conseguenza, l’Ordine Teutonico fu sciolto anche in Austria, annessa all’Impero tedesco come Ostmark . Nel 1939 lo stesso editto venne applicato nella cosiddetta Repubblica Ceca residua, il Protettorato del Reich di Boemia e Moravia, che fu annessa al Reich tedesco. In Alto Adige, ora appartenente all’Italia, ci furono attacchi ideologicamente motivati da parte dei fascisti locali contro istituzioni e membri teutonici fino al 1945.
L’ordine fu tollerato nel “Regno dei Serbi, Croati e Sloveni” e nel “Regno di Jugoslavia” (1918-1941) negli anni ’20 e ’30. Durante la Seconda Guerra Mondiale i suoi possedimenti, per lo più situati in Slovenia, furono utilizzati come ospedale militare.
Dopo il 1945 i membri dell’Ordine Teutonico nella Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia furono perseguitati a causa degli eventi bellici e del dopoguerra, anche a causa della loro denominazione. Durante l’abolizione di tutti gli ordini religiosi nel 1947, le autorità statali jugoslave secolarizzarono le proprietà dell’Ordine Teutonico ed espulsero i suoi membri dal paese.
Dopo la seconda guerra mondiale, in Austria nel 1947 il decreto di abolizione del 1938 fu annullato secondo il diritto costituzionale e i restanti beni furono restituiti all’Ordine.
I membri dell’ordine furono espulsi anche dalla Cecoslovacchia: questi membri dell’ordine fondarono nel 1949 un convento a Darmstadt, che fu abbandonato solo nel 2014. Nel 1953 fu creata una casa madre per le monache a Passau, nell’ex monastero dei canonici agostiniani di San Nicola.
Nel 1957 l’ordine acquistò una casa a Roma come sede della Procura Generale, che funge anche da luogo di assistenza per i pellegrini. Nel 1970 e nel 1988 le regole dell’ordine furono modificate, anche al fine di una migliore partecipazione delle donne.
Oggi il Deutsche Orden è un ordine religioso cattolico romano successore (legale) dell’omnimo Ordine del tempo delle Crociate. I membri dell’ordine sono canonici regolari, da quando la regola dell’ordine è stata riformata nel 1929. L’ordine conta circa 1.000 membri (a partire dal 2018), inclusi 100 sacerdoti e 200 suore che si dedicano principalmente a compiti di assistenza e beneficenza. La sede è a Vienna.
Il nome completo è ancora Ordine dei Fratelli dell’Ospedale Tedesco di Santa Maria in Gerusalemme, latino Ordo fratrum domus Hospitalis Sanctae Mariae Teutonicorum Ierosolimitanorum. L’ abbreviazione dell’ordine OT deriva dall’abbreviazione latina di Ordo Theutonicorum o Ordo Teutonicus
Attualmente conta circa 1.000 membri: circa 100 sacerdoti, 200 suore e 700 familiari .
I distretti spaziali dell’ordine sono chiamati province. Hanno propri uffici provinciali, che possono essere intesi come amministrazioni regionali dell’ordine. Questi si trovano per la Germania a Weyarn, per l’Austria a Vienna, per l’Alto Adige/Italia a Lana, per la Slovenia a Lubiana e per la Repubblica Ceca e la Slovacchia a Troppau . La provincia religiosa tedesca è organizzata come ente di diritto pubblico.
In linea con il suo ideale originario di «servire le persone bisognose con amore disinteressato per amore di Cristo», l’Ordine è ora attivo in attività caritative ed educative. L’accento è posto sui settori dell’assistenza agli anziani e dei disabili nonché dell’aiuto alle dipendenze. In Germania, i circa 3.000 dipendenti dell’ordine gestiscono 60 istituzioni senza scopo di lucro, tra cui 10 cliniche specializzate per la riabilitazione dalle dipendenze.
Possiede anche pensionati a Vienna, Roma e Gumpoldskirchen. Inoltre, in diverse parrocchie sono impiegati come parroci religiosi sacerdoti. Un altro obiettivo è la ricerca sulla storia dell’ordine. Dal 1966, l’Ordine pubblica la serie di libri Fonti e studi sulla storia dell’Ordine Teutonico, ora in 60 volumi, con la collaborazione di autori di diversi stati e denominazioni.
È governato dal Consiglio Generale: oltre al Gran Maestro, ne fanno parte il Procuratore Generale, quattro Consiglieri Generali eletti dalle province, il Segretario Generale, l’Economo Generale, oltre all’Assistente Generale, un rappresentante delle monache e un esperto dell’Istituto Famiglia. Tutte le questioni importanti per la gestione dell’ordine vengono discusse e decise dal Gran Maestro e dal suo consiglio nelle riunioni periodiche del Consiglio Generale.
Il Procuratore Generale a Roma rappresenta gli affari dell’Ordine Teutonico presso la Santa Sede.
Segretario Generale: Rappresentante amministrativo del Gran Maestro negli affari correnti e sostituto del Gran Maestro in caso di indisposizione.
Economista Generale: Responsabile della finanza e della logistica.
L’ assistente generale rappresenta le sorelle di tutte le province nel consiglio generale. In qualità di rappresentante del Gran Maestro, partecipa anche ai convegni e agli incontri dei Superiori Generali e discute le decisioni prese con il Gran Maestro, che ne informa i singoli superiori provinciali. L’Assistente generale non assume l’ufficio di superiore generale ai sensi del diritto dell’Ordine.
Il primo ramo dell’ordine è costituito dai sacerdoti che emettono un voto solenne ed eterno (professione) e, in quanto successori dei cavalieri dell’ordine, hanno il diritto esclusivo di guidare l’Ordine e sono attivi principalmente nella pastorale parrocchiale. A questo ramo appartengono anche i fratelli laici che emettono voto semplice perpetuo.
I conventi sono organizzati in cinque province (Land):
L’Austria ha sede a Vienna presso la Casa Madre dell’Ordine Teutonico.
Germania con sede nell’ex monastero dei canonici agostiniani a Weyarn, dove risiede il Priore (Landkomtur), e conventi a Weyarn, Francoforte sul Meno, Wetter e Maria Birnbaum vicino a Sielenbach. Nel 1998 il Land tedesco ha ottenuto dallo Stato libero di Baviera lo status di ente di diritto pubblico.
L’Alto Adige ha sede a Lana; il priore è anche il parroco della località.
In Repubblica Ceca (Řád bratří domu Panny Marie v Jeruzalemě) e Slovacchia (Rehola bratov domu Panny Márie Jeruzalemskej) con sede a Opava e ulteriore convento a Topoltschan.
In Slovenia (Križniški red v Sloveniji) la sede è a Lubiana.
Il secondo ramo è la Congregazione delle Religiose, che emettono i voti semplici perpetui. All’interno dell’ordine gestiscono i propri affari in modo autonomo e si dedicano alla cura dei malati e degli anziani.
Sono inoltre organizzate in cinque province:
Germania con sede a Passau, Austria con sede a Friesach, Italia con sede a Lana,
Repubblica Ceca (Milosrdné sestry Panny Marie Jeruzalemskej Provincia sestier) e Slovacchia (Milosrdné sestry Panny Márie Jeruzalemskej Provincia sestier) con sede a Opava.
Slovenia (Sestre Križniškega Reda) con sede a Luttenberg.
Il terzo ramo è l’Istituto dei Familiari (abbreviazione dietro il nome “FamOT”), detti anche Mariani. Fanno una promessa (non un voto) all’Ordine e regolano anche i loro affari in modo indipendente all’interno dell’Ordine. Nelle occasioni cerimoniali indossano un mantello nero con lo stemma dell’Ordine Teutonico sul lato sinistro. Sono divisi in balivati e commanderie presenti in Germania, Austria, Italia (Balivato Tiberino e Balivato dell’Adige e Montagna), Belgio, Boemia, Moravia, Slesia.
Una categoria speciale all’interno dei famigli è la classe dei cavalieri onorari, limitata a dodici membri. Indossano un camice bianco con lo stemma dell’ordine e la croce di cavaliere dell’ordine sul colletto.
Il simbolo dell’Ordine si è modificato nel corso dei secoli, a partire da una semplice croce nera in campo bianco.
L’abbigliamento dei membri dell’ordine sin dalla fondazione consiste in un camice bianco con la croce nera sul lato destro (visto dallo spettatore) è sempre stato un simbolo dell’Ordine. Oltre al mantello, obbligatorio nelle occasioni solenni, l’abbigliamento religioso tipico del clero comprende oggi la tonaca, la croce al collo e la croce pettorale.
La Croce Nera su sfondo bianco, utilizzata nello stemma dell’Ordine Teutonico, fu successivamente utilizzata dalle forze armate prussiane e imperiali come distintivo nazionale e decorazione militare.
Mentre la Wehrmacht tedesca utilizzava la croce sotto forma di barre con una semplice cornice bianca, la Bundeswehr utilizza ancora oggi il simbolo tradizionale in modo modificato, come una croce stilizzata con una cornice bianca.
Gli ufficiali della marina tedesca continuano ad essere addestrati presso la Scuola navale di Mürwik, il cui edificio a Flensburg – Mürwik, costruito nel 1907, è modellato sulla residenza di Marienburg (lo stemma della scuola raffigura l’edificio rosso del castello con sullo sfondo la croce nera su sfondo bianco).
Note di Massimo Ghirardi
BANDIERA RIDISEGNATA

Disegnato da: Massimo Ghirardi
BANDIERA UFFICIALE

BLASONATURA
“Drappo di bianco alla croce trasposta di nero…”
ALTRE IMMAGINI
LEGENDA