Giovanni XXII – Duèze
Giovanni XXII – Duèze
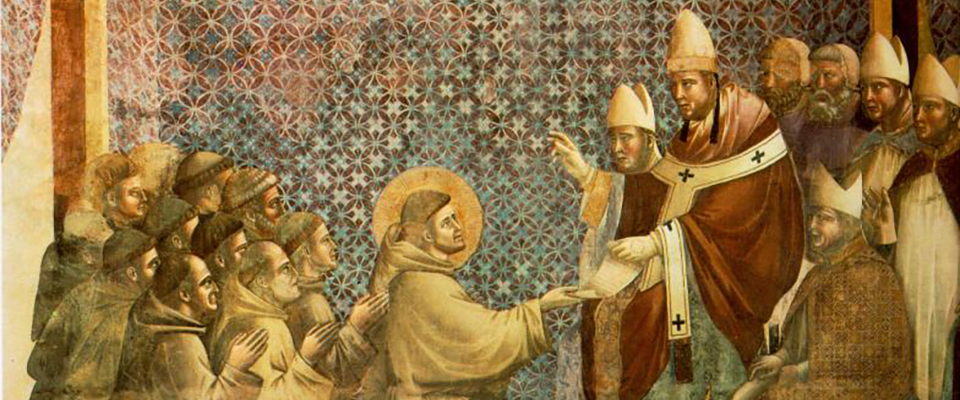
Storia e informazioni
Figlio di Arnaud Duèse, è nato a Cahors intorno al 1244, eletto papa il 7 agosto 1316 e incoronato il 5 settembre, morì ad Avignone il 4 dicembre 1334; è sepolto nella cattedrale di Notre-Dame-des-Doms.
Minuto e delicato nel fisico, aveva tuttavia una mente vivace e uno spirito arguto, e soprattutto era dotato di una notevole perspicacia politica. Unanimi sono le lodi tributate all’integrità di costumi, alla semplicità dello stile di vita, alla sincerità della devozione di questo papa.
Ebbe una formazione principalmente giuridica, acquisita a Cahors, Montpellier, Orléans, dove conseguì il titolo di dottore “in utroque jure”; pare abbia studiato anche teologia a Parigi, ma senza giungere alla licenza.
Fu docente di diritto civile.
Nel 1310, viene eletto vescovo di Fréjus. Carlo II d’Angiò lo nominò, nel 1308, cancelliere del Regno di Sicilia e a questa fase risale il primo complotto ordito contro di lui.
Dal 18 maggio 1310 Clemente V lo trasferì alla sede di Avignone, dove si era stabilita la Corte pontificia. Dunque passò dal servizio di un re a quello del papa, che gli affidò missioni delicate.
Nel dicembre 1312, all’età di sessantotto anni, fu creato cardinale titolare di San Vitale. Nell’aprile dell’anno successivo ebbe assegnato il ricco vescovato di Porto.
La sua elezione fu estremamente complessa e l’avvio del suo regno molto turbolento. Clemente V aveva previsto questa difficoltà prospettando il caso in cui i cardinali, incapaci di trovare un accordo, si fossero allontanati dal conclave, a quel punto, i pubblici poteri della città in cui si svolgeva l’elezione avrebbero dovuto costringerli a riprendere i lavori.
Di conseguenza, ventitré cardinali, in assenza di Luca Fieschi trattenuto in Italia, si riunirono nel palazzo episcopale di Carpentras intorno al 1° maggio 1314. Come previsto, fra i prelati si configurarono tre schieramenti: quello guascone che raccoglieva dieci cardinali; un gruppo italiano, che contava sette membri; un terzo partito francese, ancor più disomogeneo.
Mentre il conclave si trovava in questa impasse, nella città di Carpentras scoppiarono gravi disordini che videro fronteggiarsi servitori dei cardinali italiani e di quelli guasconi. I cardinali italiani presi di mira riuscirono ad aver salva la vita solo fuggendo dal palazzo episcopale. Fu così che il Sacro Collegio si disperse fra Avignone, Orange e Valence. La morte di Filippo il Bello vanificò i reiterati tentativi del sovrano di richiamare all’ordine i cardinali. Ma il fratello del re, conte di Poitiers, poté assolvere l’incarico di radunare i cardinali a Lione nella primavera del 1316. Il conte di Poitiers rinchiuse i cardinali nel convento dei Giacobini a Lione, dal quale non sarebbero usciti se non dopo aver eletto il nuovo pontefice. Ma le prime candidature emerse in questa situazione non trovarono un sufficiente appoggio.
A questo punto, il nome di Jacques Duèse, che figurava anche fra i papabili segnalati dal conte di Poitiers, fu proposto da tre cardinali italiani e sulla sua persona si giunse ad un accordo con i guasconi.
Allora, la maggioranza assicurata da questo consenso si trasformò in unanimità il 7 agosto 1316 e il nuovo pontefice, eletto all’età di settantadue anni, prese il nome di Giovanni XXII e si insediò rapidamente ad Avignone.
L’avvio del suo pontificato fu segnato da una serie di complotti, fra cui il più famoso è quello ordito dal vescovo di Cahors Hugues Géraud che venne accusato di voler avvelenare sia il pontefice che due suoi cardinali e che fu sottoposto a supplizio e bruciato nel settembre 1317.
Grazie ad un’abile gestione dei benefici ecclesiastici e alla messa a punto di un sistema fiscale molto valido, Giovanni XXII inaugurò una politica oculata che fece affluire ingenti ricchezze.
Il pontefice si adoperò per ridimensionare le diocesi troppo importanti. Fin dall’inizio del XIII secolo Folco di Marsiglia aveva richiamato l’attenzione sulla sua eccessiva estensione e Bonifacio VIII il 23 luglio 1295 aveva già creato la diocesi di Pamiers. Questa politica fu proseguita in Aragona e in Italia.
Quanto alla politica estera fomentò la lotta dei sovrani della penisola iberica contro i Mori, si preoccupò di rispondere all’appello dei re armeni minacciati dai Turchi, organizzò una serie di coalizioni e non ebbe pace finché non fece rientrare il re scismatico di Serbia Orose in seno alla Chiesa romana nel 1323).
Ma la propagazione della fede all’esterno rischiava di essere gravemente compromessa dalla testimonianza contrastante offerta dai dissensi interni tra i principi cristiani. Preoccupato dell’esempio dato dalla cristianità, il papa si adoperò per ristabilire la pace interna, moltiplicando gli interventi in tal senso, per evitare guerre in procinto di scoppiare in Francia, o tra questo paese e l’Inghilterra, fra i Ducati di Borgogna e d’Angiò, ma anche più lontano fra il Regno di Cipro e quello d’Armenia o la Repubblica di Genova, o più a nord fra il duca di Brabante, il conte di Fiandra e il re di Boemia.
In relazione alla povertà di Cristo, il papa stesso non comprendeva gli Spirituali francescani poiché conduceva una vita estremamente povera e non dispendiosa. Per questo appoggiò Michele da Cesena nella sua lotta contro gli Spirituali che però passò alla parte avversa appoggaindo le pretese dell’Imperatore.
L’imperatore non si accontentò più di condurre una politica ostile agli interessi del papato in Italia, dove aveva assicurato il suo appoggio a Matteo Visconti e Cangrande della Scala, ma scese lui stesso nella penisola e nel passaggio a Milano si fece incoronare re d’Italia. Poi un’assemblea popolare lo elesse imperatore a Roma e ben presto fu consacrato in questa stessa città da vescovi avversi a Giovanni XXII. Un’assemblea di laici convocata dall’imperatore depose il papa e lo sostituì con il frate minore Pietro Rinalducci di Corvaro, che assunse il nome di Niccolò V. Ma questa messa in scena ebbe vita breve. Non essendo in condizione di trattenersi in Italia, l’imperatore risalì verso nord abbandonando a Pisa l’antipapa, il quale, come la maggior parte dei tiranni delle città ghibelline, non tardò a sottomettersi beneficiando di un atto di clemenza poco consueto per il temperamento di Giovanni XXII.
Il problema più rilevante che si trovò a dirimere durante il pontificato è quello della visione di Dio. Il problema consisteva nel definire se le anime avessero la piena visione di Dio prima della ricongiunzione con i corpi. Alimentata ad arte dall’imperatore e dai minori scismatici la disputa continuò dopo la morte del pontefice con l’intento di dichiararlo eretico per sminuirne il potere spirituale.
La sua anima abbandonò questo mondo il 4 dicembre 1334, mentre il suo corpo venne sepolto nella cattedrale di Notre-Dame-des-Doms anche se, pare, che le sue spoglie siano state gettate nel Rodano durante la Rivoluzione.
Il suo stemma si blasona: “Inquartato: nel primo nel quarto d’oro, al leone d’azzurro accostato da dodici torte di rosso disposte in cinta; nel secondo e terzo di rosso, a due fasce d’oro”.
È il primo papa a porre sulle proprie armi la terza corona.
Note di Bruno Fracasso
Liberamente tratte dall’Enciclopedia Treccani

