Antipapa Onorio II – Cadalo
Antipapa Onorio II – Cadalo
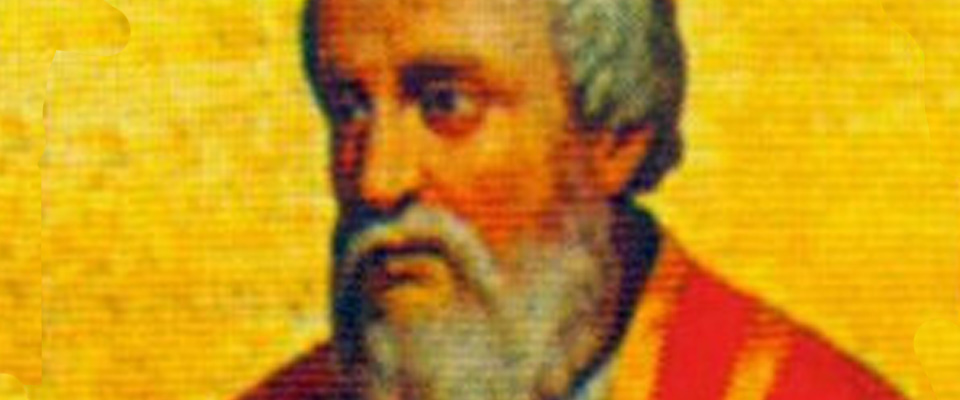
Storia e informazioni
Sulla sua nascita e la sua giovinezza i dati sono pochi e contrastanti. Cadalo (Cadolus, Cadalus, Kadalus, Cadalous, Cadelohus, Kadulus, Cadolah), di origine longobarda, è probabilmente nato verso il 1010 a Sabbion di Cologna Veneta da Ingone, figlio di Wicardo, figlio di Atone probabilmente “milites” originari di Monselice e presenti nel veronese e nel vicentino.
Il 13 luglio 1028 il padre Ingone muore e i suoi figli Cadalo, chierico, Erizo e Giovanni incrementano il patrimonio di famiglia acquistando un terreno; il 3 settembre 1030, Cadalo è designato come suddiacono, il 31 luglio 1034 è indicato come diacono. Importante passaggio nella sua carriera fu l’essere nominato “vicedominus”, visdomino, della Chiesa veronese, cioè amministratore dei beni della diocesi, come risulta da un documento di acquisto dell’11 aprile 1041. Il 24 maggio 1045, in un atto di acquisto di un terreno nel vicentino, Cadalo è definito vescovo di Parma. La sua elezione a vescovo fu probabilmente favorita dalla corte imperiale, in particolare dall’imperatrice Agnese, oltre che dal vescovo di Verona Gualtiero. Proprio da un’invettiva di Pier Damiani contro Onorio II nasce l’appellativo di “antichristi” che, nel secolo successivo, diventerà “antipapa”.
Cadalo, nel 1045, rimase unico erede dei vasti possedimenti nel vicentino e nel veronese e decide di fondare un monastero a San Giorgio in Braida.
Secondo le tesi più accreditate attualmente, la famiglia Cadalo avrebbe avuto un ramo parallelo rappresentato dalla potente famiglia degli Erzoni che acquista, nel 989, dal vescovo di Vicenza il castello di Sabbione, che poi passerà alla famiglia di Cadalo. Sembra invece che non lo si debba identificare con il Cadalo “Kadeloth” che, nel 1037, era vescovo di Naumburg e cancelliere imperiale di Corrado II Né si possa careditare un’origine origine parmense. Cadalo, nei concili di Pavia (1049), di Mantova (1052) e di Firenze (1055), venne accusato di simonia, anche se ciò non si tradusse mai in una condanna.
Dopo quasi vent’anni trascorsi come vescovo di Parma, Cadalo, riformatore moderato legato alla corte imperiale, fu scelto al concilio di Basilea del 1061 come papa da opporre ad Alessandro II, Anselmo da Baggio, deciso riformatore e sostenitore del movimento patarinico. Alessandro II aveva potuto contare sull’appoggio del potente arcidiacono Ildebrando, futuro Gregorio VII, e di tutti i cardinali vescovi riformatori. Tuttavia l’esito dell’elezione non fu comunicato all’imperatore e, grazie al sostegno militare del normanno Riccardo, principe di Capua e conte di Aversa, Anselmo da Baggio poté entrare a Roma dove, il 1° ottobre, fu consacrato papa.
Sulla base di un’ambasciata romana che offriva all’imperatore il titolo di “patricius Romanorum” l’imperatrice reggente, Agnese, decise di convocare un concilio a Basilea durante il quale Cadalo venne eletto papa assumendo il nome di Onorio II. L’elezione di ebbe l’appoggio determinante di alcuni vescovi dell’Italia settentrionale, ma si opposero Adalberto, metropolita di Brema-Amburgo, divenuto poi vicario e legato della Santa Sede, e Gerardo arcivescovo di Salisburgo, ma fu principalmente una scelta imperiale.
Il vescovo di Alba, Benzone, fu incaricato di preparare l’ingresso di Onorio II a Roma e si ingraziò la popolazione romana con la donazione di ingenti somme di denaro e avvio colloqui con Bisanzio per un’alleanza contro Alessandro II. Il 25 marzo 1062, Onorio II giunse a Sutri, dove incontrò il vescovo di Alba e la nobiltà romana. Lo scontro armato tra le fazioni di Onorio II e di Alessandro II avvenne alle porte di Roma, il 14 aprile: Onorio II conquistò la città leonina, mentre Alessandro II si ritirava nel monastero di Santa Maria sul Campidoglio. Nel frattempo, in Germania, l’arcivescovo di Colonia Annone, insieme con il metropolita di Brema-Amburgo Adalberto, avevano sostituito Agnese nella reggenza dell’Impero. L’arrivo a Roma del duca Goffredo di Lorena a capo di un ingente esercito, oltre a rendere manifesta l’intenzione del duca di porsi quale arbitro delle vicende italiane, aprì una nuova fase nella lotta fra i due contendenti; infatti Goffredo, contrario ai Normanni, ma non ostile ad Alessandro II per le pressioni della moglie Beatrice di Canossa chiese ai due papi di ritirarsi nelle rispettive diocesi. Mentre Onorio II rifiutò, Alessandro II obbedì e si recò nella sua diocesi di Lucca, dove rimase almeno fino a dicembre.
Forse su iniziativa dell’arcivescovo Annone venne convocato un concilio ad Augusta il 24 ottobre 1062 per affrontare la questione della legittimità dell’uno e dell’altro papa. In difesa di Alessandro II si presentò Pier Damiani, cardinale vescovo di Ostia. L’argomento principale a favore di Alessandro II era costituito dal fatto che, solo perché costretti dalle circostanze difficili, i cardinali non avevano dato immediatamente notizia all’imperatore dell’avvenuta elezione. Così facendo, Pier Damiani minava le fondamenta stesse su cui si era fondata l’elezione di Onorio II. Il concilio fu quindi piuttosto favorevole ad Alessandro II, anche se non si pronunciò in maniera definitiva.
Alessandro II, nel marzo 1063, era tornato a Roma e il mese successivo, in Laterano, riunì in concilio più di cento vescovi che scomunicarono Onorio II. Questi rispose con un concilio riunito a Parma, nel maggio 1063, ove scomunicò Alessandro II perché si sarebbe avvalso per la sua elezione dell’aiuto dei Normanni, nemici dichiarati dell’Impero. Raccolto molto denaro, forte di un esercito lombardo e di alcune fazioni della nobiltà romana, Onorio II riuscì a tornare a Roma nel maggio 1063, occupando Castel Sant’Angelo e San Pietro.
Tuttavia, la sua conquista non risultò stabile perché la protezione armata si stava trasformando in una prigionia, dato che Onorio II era costretto a risiedere nella torre che Cencio possedeva sul Tevere davanti a Castel Sant’Angelo, potendone uscire solo dopo il pagamento di 300 piastre d’argento.
Pier Damiani, allora legato papale in Francia, prese l’iniziativa di scrivere all’arcivescovo Annone chiedendogli di convocare un altro concilio, ma il suo intervento fu severamente criticato dall’arcidiacono Ildebrando e disapprovato da Alessandro II perché attribuiva così alla corte imperiale l’autorità di legittimare o meno l’elezione pontificia. In realtà, proprio grazie al concilio di Mantova del 31 maggio 1064, lo scisma si compose in maniera pressoché definitiva a favore di Alessandro II. Il concilio rifiutò la presidenza ad Onorio II, che per questa ragione non vi partecipò. Alessandro II invece accettò di rispondere ad Annone circa le accuse di simonia e di alleanza con i Normanni contro l’Impero. La sua difesa, quanto alla simonia, si basò sul fatto di esser stato eletto contro la propria volontà e, per quel che riguardava i rapporti con i Normanni, nemici dell’Impero, il papa invitò il re a farsi incoronare a Roma, verificando così di persona la fondatezza dell’accusa. Inoltre, Alessandro II ribadì più volte che il re non aveva alcun potere sull’elezione pontificia e che, nel suo caso, tutto si era svolto secondo le prescrizioni del Decretum di Niccolò II.
Il concilio depose e scomunicò Onorio II e l’arcivescovo di Milano, Guido, e altri vescovi lombardi finirono con l’accettare Alessandro II.
A Onorio II non restò che tornare a Parma. In due occasioni si mostrò disponibile a riprendere le vesti papali: quando, nel 1065, Enrico IV fu dichiarato maggiorenne e l’equilibrio tedesco si spostò in suo favore fino alla Dieta di Tribur che riportò il tutto all’equilibrio precedente; e quando, nel 1068, Enrico IV, volle mostrare il suo dissenso nei confronti della politica di Alessandro II, favorevole ai Normanni da una parte e ai Patarini lombardi. La reazione di Alessandro II fu durissima: comminò la scomunica ad Enrico IV e ad Annone, che era a capo dell’ambasceria, e assolse entrambi solo dopo che si furono emendati.
Onorio II non ebbe più occasioni di far valere la sua elezione e morì nel 1071 o nel 1072 a Parma.
Lo stemma di Onorio II si blasone: “Troncato: nel PRIMO d’oro all’aquila di nero, dal volo spiegato, posta sulla troncatura, con il capo rivoltato; nel SECONDO d’argento alla fascia diminuita e ristretta, doppiomerlata”.
Note di Bruno Fracasso
STEMMA RIDISEGNATO

Disegnato da: Massimo Ghirardi
STEMMA ACS

STEMMA UFFICIALE

LOGO

BLASONATURA
“Troncato: nel PRIMO d’oro all’aquila di nero, dal volo spiegato, posta sulla troncatura, con il capo rivoltato; nel SECONDO d’argento alla fascia diminuita e ristretta, doppiomerlata”.
ALTRE IMMAGINI
LEGENDA