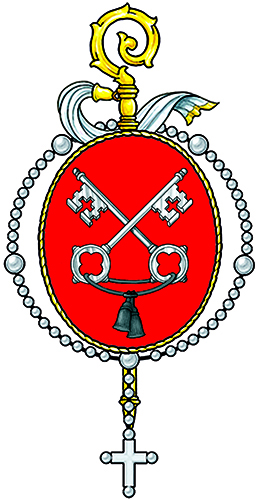Abbazia di San Pier Maggiore di Firenze
Abbazia di San Pier Maggiore di Firenze

Storia e informazioni
Fondata nei primi mesi del 1067 poco fuori le mura di Firenze, presso quella porta che dalla stessa abbazia prese nome, quella di San Pier Maggiore fu per lungo tempo il più importante cenobio di donne della città. Ne fu promotore il vescovo fiorentino Pietro Mezzabarba, che in quegli stessi anni era posto sotto accusa dai monaci Vallombrosani guidati da Giovanni Gualberto, imputato di simonia per aver ottenuto la cattedra episcopale corrompendo la corte imperiale con ingenti somme di denaro. Nonostante il momento delicato, il vescovo era forte del sostegno dei più facoltosi fiorentini, tra i quali si distinse Ghisla di Rodolfo, nobildonna di origine longobarda, all’epoca vedova di Azzo di Pagano, che dotò l’abbazia con la quarta parte dei propri ingenti beni, costituiti da una rete di corti, castelli e chiese diffusa tra Valdarno Superiore, Val Marina, Val di Sieve e Mugello. Con la morte di Rolando, unico figlio maschio, la «potente e nobile matrona» prese il velo in quel monastero assieme alle quattro figlie Gisla, Guazza (che furono anche badesse), Adalasia e Linia.
L’importanza dell’abbazia, che obbediva alla regola benedettina, è sottolineata da un particolare e caratteristico rituale, secondo il quale spettava alla badessa di San Pier Maggiore il compito di insediare il nuovo vescovo. Il presule, accolto dai notabili fiorentini, veniva accompagnato fino al sagrato dell’abbazia sotto un baldacchino. Smontato da cavallo, che secondo la consuetudine restava in dono alla badessa, il vescovo entrava in chiesa, dove i sacerdoti lo incensavano e lo aspergevano con l’acqua santa. Dopo aver pregato davanti all’altare maggiore, veniva posto a sedere su un apposito trono, sotto un baldacchino di preziosa tela d’oro. Dopo questo insediamento la badessa si prostrava dinanzi al vescovo, che la faceva sedere alla sua destra. Il rito culminava con la cerimonia dello sposalizio rituale, col vescovo che poneva al dito della badessa un anello d’oro con una gemma preziosa. Dopo aver benedetto il popolo e pubblicato l’indulgenza, il vescovo col più stretto seguito si recava a desinare nel contiguo monastero, nel quale trascorreva anche la notte.
Il significato di questa cerimonia, dal sapore ancestrale, sottolineava il legame che il presule si assumeva come nuovo Pastore della chiesa fiorentina, idealmente rappresentata dalla badessa di San Pier Maggiore che, per questa sua peculiarità, veniva popolarmente detta la “sposa del vescovo”. Solo la mattina seguente il presule si sarebbe recato presso la cattedrale, per un secondo insediamento. Il rito, il cui complesso cerimoniale fu stabilito dalla Repubblica fiorentina nel 1385, venne abolito da papa Gregorio XIII (1572-1585). In ogni caso non si tratta di un unicum: se ne conoscono versioni del tutto simili anche a Pistoia, Fiesole e probabilmente in altre civitas toscane.
La chiesa di San Pier Maggiore venne completamente ristrutturata nel 1638 su progetto di Matteo Nigetti. In quell’occasione venne realizzato il portico antistante la facciata, sul quale spicca una iscrizione che ricorda il nome di Luca degli Albizi, finanziatore dell’intervento.

Stemma della famiglia Albizi
Artisti del calibro di Andrea Orcagna, Sandro Botticelli, il Perugino, Desiderio da Settignano, Ridolfo del Ghirlandaio arricchirono l’edificio sacro di pregevoli opere d’arte. Ciò nonostante nel 1783 la chiesa fu ritenuta pericolante a causa di alcuni crolli, tanto che il granduca Pietro Leopoldo, temendo per la stabilità dell’intero complesso, l’8 luglio 1784 ordinò che chiesa e campanile fossero abbattuti, e il monastero secolarizzato. Tale operazione risente tuttavia del desiderio del granduca di ridurre il più possibile la presenza di istituzioni religiose in città, culminata l’anno successivo con la soppressione delle confraternite laicali. Le opere d’arte vennero in parte trasferite nelle chiese vicine, e in parte vendute; oggi arricchiscono prestigiose collezioni, quasi tutte nei paesi anglosassoni.
Oggi della chiesa resta solo il portico, dal cui ingresso principale si dirama una strada (via di San Pier Maggiore) lungo quella che fu la navata principale. Le forme della chiesa restano documentate nel Miracolo di san Zanobi di Ridolfo del Ghirlandaio (nel suo aspetto gotico trecentesco), oggi al Museo dell’Accademia, mentre quelle immediatamente antecedenti la demolizione ci vengono tramandate grazie a una incisione di Giuseppe Zocchi (1744).
Lo stemma dell’abbazia di San Pier Maggiore, del quale resta un esemplare lapideo murato sull’edificio che un tempo ne fu sede, si blasona: di rosso alle chiavi di san Pietro decusse d’argento, gli ingegni in alto, legate di nero. Su due capitelli che coronano i pilastri del prospetto è ancora leggibile l’arme della famiglia Albizi: di nero, a due cerchi concentrici d’oro, con il capo d’argento caricato della croce di nero.
Note a cura di Michele Turchi
Bibliografia
- Zocchi, Scelta di XXIV vedute delle principali Contrade, Piazze, Chiese e Palazzi della Città di Firenze, Firenze, 1744, tav. XVII.
- Richa, Notizie istoriche delle chiese fiorentine divise ne’ suoi quartieri, vol. I, 1754.
Guido Carocci, La chiesa di San Pier Maggiore e la sua demolizione, in “L’Illustratore fiorentino”, Calendario Storico anno 1912, IX, Firenze, 1911.
- Bargellini, E. Guarnieri, Le strade di Firenze, Firenze, 1977-1978, vol. III.
M.E. Cortese, Signori, castelli, città. L’aristocrazia del territorio fiorentino tra X e XII secolo, Firenze, 2007.
M.E. Cortese, “Potens ac nobilis matrona”. Gisla figlia di Rodolfo (Firenze, secolo XI), in Ritratti di donne: una Storia di esperienze, a cura di T. Lazzari e I. Lazzarini, Genova, 2024.