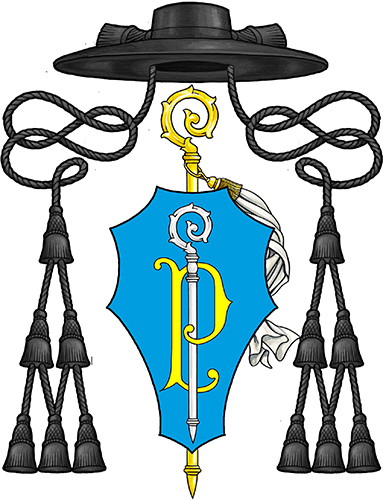Abbazia di San Michele Arcangelo a Passignano
Abbazia di San Michele Arcangelo a Passignano

Storia e informazioni
Situata nel territorio delle colline del Chianti, nel comune di Barberino Tavarnelle, la ricca e potente abbazia di San Michele Arcangelo a Passignano, al di là della sua funzione religiosa, ha svolto un ruolo di primaria importanza nelle vicende storiche e politiche del territorio chiantigiano.
La sua fondazione si fa risalire all’epoca longobarda, che l’intitolazione all’arcangelo Michele sembrerebbe confermare, stante la particolare venerazione tributata all’angelo guerriero da parte di quel popolo. Il suo leggendario fondatore sarebbe stato un certo Sichelmo, che un ufficio in suffragio riportato nel Rituale Passinianense del 1316, prescritto in data 18 ottobre, sembrerebbe confermare; vi si legge infatti «de officio Sichelmi, qui hedificavit hoc monasterium». L’atto più risalente conservato dall’immenso archivio del monastero, purtroppo in larga parte disperso, fu qui rogato nel marzo dell’884, redatto alla presenza di un Wilerado scabino. Da un atto datato 27 marzo 903 si sa che nell’allora oratorio di san Michele a Passignano viveva una famiglia monastica presieduta da un abate e un proposto.
Nell’XI secolo la comunità fu tra le prime ad accogliere la riforma monastica di Vallombrosa, promossa da Giovanni Gualberto, divenendo una delle sedi della lotta contro la simonia. Lo stesso Giovanni Gualberto, nato in quello stesso territorio, soggiornò a lungo a Passignano, dove nel 1050 incontrò papa Leone IX. Dopo una vita passata a combattere contro la simonia, qui morì il 12 luglio 1073 e fu sepolto; il 1º ottobre 1193 fu canonizzato da papa Celestino III.
San Michele a Passignano fu definito «il più insigne tra i monasteri vallombrosani», per il fatto di custodire i resti mortali di san Giovanni Gualberto, ma anche e soprattutto in virtù del ricco patrimonio, accumulato attraverso donazioni e acquisti, consistente in numerosi poderi nel Chianti e molti edifici adibiti al culto o all’accoglienza dei pellegrini, dei malati e dei poveri. Questa connotazione presentò in certi periodi una connotazione conflittuale con la Casa madre, resa difficile dalla posizione quasi concorrenziale che Passignano assunse nei confronti di Vallombrosa.
Il monastero – ubicato non lontano dai confini tra il contado fiorentino e quello senese, e limitrofo alla Valdelsa in cui era ancora forte il potere feudale degli Alberti e dei Guidi – si trovava spesso vittima delle ostilità tra le due città rivali, subendo gravi danni in conseguenza di eventi bellici.
Nel 1125 il territorio sottoposto alla pieve di San Pietro a Sillano – che comprendeva anche il monastero di Passignano – fu ceduto alla diocesi di Fiesole, in risarcimento dei territori fiesolani che il vescovo di Firenze aveva occupato nel Mugello. Il distacco dalla diocesi fiorentina portò un mutamento della politica del monastero, che si avvicinò a seguire sempre più da vicino gli orientamenti politici di Siena, scelta che in più di una occasione si ritorse contro la vita del monastero.
Negli anni Sessanta del XII secolo, durante il pontificato di Alessandro III si verificò uno scisma che portò all’elezione di un antipapa, evento che causò profonde ripercussioni sull’intera congregazione vallombrosana; anche all’interno del monastero di Passignano si formarono due fazioni, con conseguenti disordini. La massima tensione si raggiunse nel 1168, quando Giovanni, abate del monastero vallombrosano di Strumi, venne nominato quale antipapa col nome di Callisto III.
L’Italia centrale era in quegli anni al centro degli interessi di molteplici potenze: le ricche città Comunali in cerca di espansione territoriale, le ancora forti casate comitali, la Chiesa e l’Impero in cerca di consensi politici e militari; perfino l’imperatore di Costantinopoli ordiva intrighi con l’obiettivo di compensare la perdita delle terre che i Normanni gli avevano sottratto nel Meridione. Passignano in quegli anni aveva stretto alleanza con i conti Alberti, impegnati nella fondazione, in chiave anti-fiorentina, della terra di Semifonte. Il monastero aveva pienamente appoggiato l’iniziativa, realizzando una chiesa e un ospedale. I fiorentini però non tollerarono una simile iniziativa nel loro contado; con due assalti ravvicinati, nel 1196 e nel 1202, espugnarono Semifonte, per poi demolirne gli edifici fin dalle fondamenta. Anche Passignano subì delle conseguenze, con una pesante tassa di 124 libbre destinata alla sistemazione dei superstiti abitanti di Semifonte.
Nel 1222, Passignano e gli altri monasteri vallombrosani si trovarono al centro di una contesa con il vescovo di Fiesole Ildebrando, a causa delle esenzioni fiscali. Nel corso della disputa si scatenò un parapiglia; il vescovo non si limitò a difendere le proprie ragioni, ma pronunciò delle vere e proprie maledizioni nei confronti dei monasteri ribelli, auspicando che ai loro beni fosse appiccato il fuoco.
Nel 1229 il papa dichiarò guerra all’imperatore Federico II, imponendo pesanti tasse ai monasteri toscani per coprire le spese militari. I vallombrosani furono costretti a impegnare quasi tutto il loro patrimonio, che nel 1245, dopo una sentenza del tribunale, cadde in mano ai creditori. I beni di Passignano passarono alla famiglia ghibellina degli Scolari, che nel 1255 occuparono il monastero tenendo prigionieri i monaci, devastando il monastero e la chiesa. Nel 1269, col ripristino dell’egemonia guelfa, fu insediato l’abate Ruggero Buondelmonti, che promosse la ricostruzione della chiesa, del monastero e del campanile, interventi terminati nel 1297.
Nel 1312 l’abate si oppose all’imperatore Enrico VII di Lussemburgo, le cui truppe avevano occupato il monastero di San Salvi durante il fallito assedio a Firenze. Inserito tra i ribelli all’impero, nel mese di novembre il monastero fu posto sotto l’assedio, e nonostante fosse stato trasformato in fortezza, venne espugnato e invaso fino al marzo successivo, con gli occupanti che più volte minacciarono di raderlo al suolo. Cosa che non avvenne, e che i monaci attribuirono a un miracolo della Madonna cui avevano fatto voto. Le vicissitudini non erano tuttavia finite, in quanto fra i prigionieri fatti da Castruccio Castracani nel 1325 dopo la battaglia di Altopascio figuravano tre monaci di Passignano.
Nel XIV secolo le risorse del monastero era tornate floride, come dimostra l’entità della tassa annuale, che ammontava a 320 moggia di grano (un moggio corrispondeva a 585 litri). Questo consentì la commissione di raffinate opere d’arte, quali il reliquiario di san Giovanni Gualberto e il polittico dell’altare maggiore, realizzato a Siena nel 1358.
All’inizio del 1441 Francesco Altoviti venne nominato abate di Passignano; sotto il suo governo il monastero prese gran parte delle forme che ancora oggi è possibile vedere. Fu in quegli stessi anni che alcuni cenobi vallombrosani presero ad organizzarsi secondo la riforma attuata nel monastero padovano di Santa Giustina. Vi furono delle discordie in seno all’Ordine, che richiesero lunghe discussioni e mediazioni prima che si arrivasse a un’intesa, approvata da papa Pio II nel 1463. La nuova bozza trasformò l’ordine in congregatio, organizzata sul modello di Santa Giustina e dava facoltà agli altri monasteri di aderirvi. Ma la concordia non durò molto, dando luogo a uno scisma e nuove controversie. Nel 1485 si stabilì di mettere fine alla precedente congregazione, dando vita alla nuova Congregazione di Santa Maria in Vallombrosa, con l’obbligo per tutti i monasteri dell’ordine ad aderirvi. Passignano tuttavia venne esentato, in quanto per ordine di Lorenzo de’ Medici, con la giustificazione che essendo posto in una zona militarmente strategica, quasi al confine con Siena, non poteva essere governato da abati annuali ma doveva essere una diretta dipendenza dello stato fiorentino. Ma la nomina del nuovo abate non piacque al Magnifico, che organizzò una spedizione punitiva per sequestrare i monaci e deportarli nel monastero fiorentino di San Salvi.
Verso la fine del XV secolo i lavori di ampliamento, che avevano visto all’opera maestranze lombarde e gli scalpellini di Settignano, erano ormai terminati. Per le pitture erano stati chiamati, fra gli altri, i fratelli David e Domenico del Ghirlandaio e Bernardo di Stefano Rosselli.
Nel XVI secolo la ricchezza del monastero portò i monaci a progettare l’ampliamento della chiesa abbaziale e la realizzazione di un monumento funebre a san Giovanni Gualberto, lavori che tuttavia non vennero portati termine a causa del ritorno al potere dei Medici, che destituirono l’abate, mandandolo in esilio. Fu solo nel 1515, in occasione della vista di papa Leone X al santuario dell’Impruneta, che fu siglata una pace con la famiglia Medici.
Nel 1549 ripresero speditamente i lavori per la trasformazione della chiesa in stile manierista-barocco, con decorazioni a fresco e cartoni di Alessandro Allori. Una nuova fase dei lavori, dal 1598 al 1602, fu diretta da Domenico Cresti, detto il Passignano per i suoi natali; l’intera chiesa venne trasformata, con la costruzione della cappella maggiore in luogo dell’abside romanica, la realizzazione della cupola, delle volte nel transetto e della navata. Lo stesso Passignano eseguì gli affreschi e numerose tele.
L’avvento del principato mediceo, e soprattutto la conquista dello Stato di Siena, diminuì notevolmente il peso politico dell’abbazia. Lo stesso Ordine Vallombrosano, ridimensionato dal Concilio di Trento e dalla Controriforma, perse di importanza. Ripreso il nome di Congregazione di Santa Maria di Vallombrosa, cambiò anche la sede, che nel 1550 venne posta nel monastero di San Bartolomeo a Ripoli, dove risiedevano l’abate generale e la curia generalizia.
In questo periodo Passignano accentuò l’aspetto monastico e divenne sede di uno studentato. Vi presero sede i monaci più dotti dell’intera Congregazione, che insegnavano le lingue greca ed ebraica per poter studiare le sacre Scritture, e si iniziò uno studio approfondito della matematica e le scienze esatte. Per queste materie nel 1588 fu chiamato anche Galileo Galilei, che in gioventù aveva avuto un’esperienza monastica a Vallombrosa.
Alla metà del XVIII secolo la comunità di Passignano era formata da 25: sei monaci sacerdoti, 3 monaci conversi, dieci studenti e sei laici. I beni del monastero comprendevano 41 poderi e 80 case coloniche, con un territorio di 12 chilometri quadrati di superficie. Il 10 ottobre 1810 il monastero venne tuttavia soppresso dalle leggi napoleoniche. La vita monastica di Passignano si interruppe, l’intero patrimonio archivistico e tutta la biblioteca vennero dispersi, i beni immobili dati in affitto.
Con la Restaurazione del Granducato vennero restituiti all’Ordine il monastero di Vallombrosa, il Santuario di Montenero e la chiesa di Santa Trinita a Firenze. Solo nel 1818 i Vallombrosani riuscirono a riacquistare Passignano e l’intera tenuta, dove venne ricostituita una piccola comunità, ma fu possibile nominare un abate solo nel 1858, quando i minaci erano più numerosi. Ma non durò troppo a lungo. Nel 1866 le leggi Siccardi emanate dal Regno sabaudo soppressero tutti gli ordini religiosi, accorpando al demanio tutti i loro beni. Una piccola parte del monastero di Passignano venne assegnata in custodia ai pochi monaci rimasti, mentre la chiesa fu assegnata alle funzioni parrocchiali per il borgo. La badia di Passignano venne messa all’asta e acquistata nel 1870 dal conte Maurizio Dzieduszycki. A lato della chiesa fatta costruire la canonica, nella quale vennero ospitati i pochi monaci rimasti.
Dopo una successione di vari proprietari nell’arco di un secolo, il 10 ottobre 1986 con una solenne cerimonia i monaci vallombrosani hanno ripreso possesso del monastero, che dopo un restauro durato un quarto di secolo è di nuovo visitabile.
Nota a cura di Michele Turchi
Bibliografia
- Repetti, Dizionario geografico, fisico, storico del Granducato di Toscana, Firenze, 1833-1846.
- Fornaciari, La Badia di Passignano, Firenze, 1903.
- VV., Fiesole. Una diocesi nella storia, Fiesole, 1986.
- Stopani, Civiltà romanica nel Chianti, Poggibonsi, 1995.
- Pirillo (a cura), Passignano in Val di Pesa. Un monastero e la sua storia, I, Firenze, 2009.