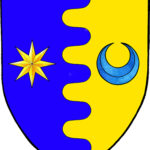Comune di Buti – (PI)
Articoli correlati

Info
- Codice Catastale: B303
- Codice Istat: 50002
- CAP: 56032
- Numero abitanti: 5856
- Nome abitanti: butesi
- Altitudine: 85
- Superficie: 23.08
- Prefisso telefonico: 0
- Distanza capoluogo: 25.9
- Comuni confinanti:
Bientina, Calci, Capannori, Vicopisano.
- Santo Patrono: Santissimo Nome di Maria
Storia del Comune e informazioni Emblemi civici
Rammentata col nome di «Buyti» in una carta di donazione datata al 960, Buti conserva tracce (monete e pietre lavorate) di un insediamento già esistente in epoca etrusco-romana. Il toponimo deriva dal termine tardo latino bucita, col senso di “pascolo di buoi”.
Il borgo medievale si aggregò attorno alla pieve intitolata a San Giovanni Battista, alla quale facevano riferimento i villaggi della vallata. Sorto probabilmente come caposaldo a difesa dei confini della Repubblica Pisana, il paese dovette subire più volte gli effetti devastanti delle violente guerre fratricide tra Pisa e Lucca, e in seguito quelle portate dall’oste fiorentina in guerra con Pisa.
Il paese, che aveva conosciuto una certa prosperità grazie alla produzione di olio d’oliva – già nell’anno 679 sono documentati due ricchi mercanti di Lucca che venivano a Buti per acquistare il pregiato olio che vi si produceva – ma anche vino e castagne. La vallata era inoltre mèta dei pastori, che fin dalla preistoria vi praticavano la transumanza, facendo spola tra l’Appennino Tosco-Emiliano e il Monte Pisano.
Nel XV secolo, a causa delle frequenti epidemie, la vallata si spopolò e molti terreni rimasero incolti; ma già nel secolo successivo iniziò gradualmente a ripopolarsi, grazie soprattutto all’immigrazione di famiglie di boscaioli provenienti dalla Garfagnana e dal Frignano, come risulta dai registri parrocchiali; qui giunti, si trasformarono in agricoltori, falegnami e muratori. Resta memoria perfino di fabbri provenienti dal Tirolo e dal Canton Ticino.
Sotto il Granducato di Toscana, oltre alla lavorazione e al commercio dell’olio, venne incoraggiata anche la lavorazione del legname di castagno, in particolare la produzione di ceste e corbelli. Fu soprattutto nel corso dell’Ottocento che Buti ritrovò la sua prosperità, grazie alla presenza di numerose fattorie padronali che producevano e commercializzavano il vino e soprattutto il pregiato olio d’oliva di produzione locale. Notevole anche l’apporto della lavorazione del castagno, sia come prodotto alimentare (castagne e farina) che per la lavorazione del legname per farne travi, mobili, ceste e corbelli. C’era inoltre una buona pastorizia, sia stabile che di transumanza, nonché una piccola industria estrattiva data dalle cave di ardesia.
La prosperità dette impulso ad aggregazioni religiose come l’Arciconfraternita di Misericordia, sorta dalle ceneri delle preesistenti tre Compagnie medievali. Sorsero anche aggregazioni laiche come la Pubblica Assistenza, la Società Filarmonica e l’Accademia dei Riuniti, alla quale si deve la costruzione del Teatro dedicato a Francesco di Bartolo.
Il ritrovato sviluppo economico e sociale dette impulso all’erezione di Buti a Comune autonomo, con Regio Decreto in data 9 giugno 1867, trovandosi fino a quella data compreso nel territorio di Vicopisano.
La Giunta della nuova municipalità, con Deliberazione del 4 ottobre 1867, ne approvò lo stemma, descritto come «un’aquila, avente negli artigli un ramo di olivo ed un ramo di castagno, con corona in testa, in campo d’oro». L’aquila, animale totemico di Pisa, rappresenta l’appartenenza al contado di quella città; i rami fruttati di olivo e di castagno che il rapace tiene negli artigli rappresentano i prodotti più tipici del territorio.
Tale deliberazione venne comunicata alla Regia Prefettura di Pisa, la quale, con nota n. 1769/Div. 2 del 10 ottobre 1867, specificava che «il Municipio comprovi, con documenti o con dati storici, la preesistenza ed il possesso immemorabile di detto stemma e che se ne ottenga l’approvazione con Rescritto Sovrano, ritenendosi nelle prerogative della Corona la concessione di tale distintivo, ove non esista la prova di possesso immemorabile predetto». Le prove vennero fornite per mezzo di alcune memorie conservate presso l’archivio della Pieve di Buti, che si trovano allegate, insieme al bozzetto dello stemma, allo Statuto comunale attualmente in vigore, l’art. 2 del quale specifica quanto sopra descritto. Il gonfalone reca un drappo di colore bianco.
Il Comune di Buti è gemellato con la cittadina francese di La Seyne Sur Mer.
(Nota di Michele Turchi)
Bibliografia:
– E. Repetti, Dizionario Geografico, Fisico, Storico della Toscana, Firenze 1833-46.
– L. Passerini, Le armi dei Municipj Toscani, Firenze 1864.
– D. Herlihy, Pisa nel Duecento. Vita economica e sociale d’una città italiana nel medioevo, Pisa 1973.
– G. Caciagli, La Badia di San Salvatore del Lago di Sesto, Pontedera 1984.
– G.P. Pagnini, Stemmi e gonfaloni della Toscana, in La Toscana e i suoi Comuni. Storia territorio popolazione e gonfaloni delle libere Comunità Toscane, Firenze 1985.
– Gli stemmi dei Comuni toscani al 1860, a cura di G.P. Pagnini, Firenze 1991.
– V. Favini, A. Savorelli, Segni di Toscana. Identità e territorio attraverso l’araldica dei comuni: storia e invenzione grafica (secoli XIII-XVII), Firenze 2006.
– E. Valdiserra, Storia di Buti, in <http://www.lidoscarpellini.it/>
– Comune di Buti, Statuto, 2013.
STEMMA RIDISEGNATO

Fonte: Sito istituzionale
Disegnato da: Bruno Fracasso
STEMMA ACS

STEMMA UFFICIALE

LOGO

SMALTI
ALTRE IMMAGINI
Stemma in uso nel 1995.
http://www.lidoscarpellini.it/buti/comune/index_file/Page325.html

Stemma in uso nel 1905.
http://www.lidoscarpellini.it/buti/comune/index_file/Page325.html

Stemma in uso nel 1899.
http://www.lidoscarpellini.it/buti/comune/index_file/Page325.html
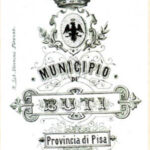
Stemma in uso nel 1892.
http://www.lidoscarpellini.it/buti/comune/index_file/Page325.html

Stemma in uso nel 1877
http://www.lidoscarpellini.it/buti/comune/index_file/Page325.html

Stemma in uso nel 1873
http://www.lidoscarpellini.it/buti/comune/index_file/Page325.html

Stemma ridisegnato come da stemma sul gonfalone.

GONFALONE RIDISEGNATO

Disegnato da: Bruno Fracasso
GONFALONE UFFICIALE

BLASONATURA
“Drappo di colore bianco…”
COLORI
ALTRE IMMAGINI
BANDIERA RIDISEGNATA

Disegnato da: Bruno Fracasso
BANDIERA UFFICIALE

BLASONATURA
“Drappo di bianco…”
ALTRE IMMAGINI
LEGENDA
- stemma
- gonfalone
- bandiera
- sigillo
- città
- altro
- motto
- istituzione nuovo comune